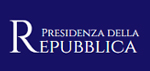Italia-Giappone: Ca' Foscari, 2 tomi d'analisi su ruolo dei due Paesi tra 1935 e 1952
27-01-2023 18:02 - Opinioni

GD - Venezia, 27 gen. 23 - Il Giappone non è proprio dietro l'angolo e con esso sono spesso sconosciuti gli avvenimenti che caratterizzano le relazioni del Paese con l'Italia in un periodo cruciale per la storia mondiale. Ad aprire un ampio e documentato spiraglio su questo spaccato di storia e geopolitica è una ponderosa opera, di analisi e ricerca, in due tomi, compiuta da Massimo Gusso, studioso indipendente, politologo e storico, intitolata «Italia e Giappone: dal Patto Anticomintern alla dichiarazione di guerra del luglio 1945 - Inquiete convergenze, geopolitica, diplomazia, conflitti globali e drammi individuali (1934-1952)», pubblicato dall'Editrice Ca' Foscari - Venice University Press, Venezia 2022, nella Collana Japanese Studies nr. 20 (History and Society nr. 4), con la prefazione del prof. Marco Del Bene, della Sapienza Università di Roma.
Nell'Era dei regimi totalitari il rapporto tra Italia e Giappone, pesantemente influenzato dall'ingombrante presenza tedesca, fu reciprocamente ambiguo: il nippofilo Mussolini diffidava, in realtà, dell'alleato orientale, e l'armistizio dell'8 settembre 1943 confermò tragicamente, alla fine, i costanti dubbi nipponici su un'Italia dove, successivamente (luglio 1945), il Governo democratico presieduto da Parri si sarebbe spinto a dichiarar guerra all'ex alleato, poco prima della conferenza di Potsdam. Per tentar di risollevare le sorti politico-diplomatiche dell'Italia sconfitta, Parri e i suoi, non senza affanni, presero la decisione di schierarsi contro il Giappone: l'inattesa resa giapponese vanificò la spericolata scelta, che sarebbe tuttavia ingeneroso banalizzare. Nel nuovo contesto della Guerra Fredda, ripristinare normali relazioni tra i due paesi, pur dopo una guerra non combattuta, si rivelò assai difficoltoso, dagli inizi (1951-52) e per un lungo ventennio di sfibranti trattative.
Il libro, come si comprende da titolo e sottotitolo, rappresenta un'ampia analisi sul ruolo giocato da Italia e Giappone tra la metà degli anni '30 agli inizi degli anni '50 del Novecento (e sulle loro reciproche e altalenanti simpatie, relazioni, alleanze e animosità), il tutto inserito e inquadrato in un'esposizione del contesto reticolare, politico e geopolitico, che va dalla Seconda Guerra mondiale al primo dopoguerra.
Si potrebbe sintetizzare il lavoro dicendo che si tratta di una serie di narrazioni, articolate tra loro: il racconto, ogni qualvolta è stato possibile, è stato arricchito con le parole dei protagonisti, attraverso i documenti. Per alcuni contesti, in particolare, è stata fondamentale la ricerca effettuata, a Roma, all'Archivio Storico-Diplomatico del Ministero degli Esteri.
Si tratta di vari piani “narrativi”, quello degli anni Trenta del '900, quando si forma il diabolico congegno che porterà alla più devastante guerra mai vista dall'uomo, a cui Italia e Giappone contribuirono non poco; poi la storia della caduta di Mussolini e dell'Armistizio dell'8 settembre, vista con gli occhi di chi restò travolto dagli eventi in Asia orientale, e in particolare la vicenda politica e umana dei diplomatici italiani in Giappone, finiti in prigionia per non aver accettato di mettersi al servizio della neonata Repubblica fascista; la narrazione della vicenda della dichiarazione di guerra italiana al Giappone, nel luglio del 1945, a guerra terminata in Europa – la parte del lavoro più inedita e meno studiata su una vicenda molto singolare - è incentrata soprattutto sulla ‘costruzione' di una decisione che sembra oggi fuori dal senso comune, ma che meritava di essere raccontata, dagli stentati esordi a una fine ingloriosa (o peggio per chi l'ha raccontata senza contestualizzarla). Alla fine, si trova l'importante narrazione di raccordo sulla faticosa ripresa delle relazioni italo-giapponesi. Nonostante la mole, che può forse inquietare, il libro è sorretto davvero da un impulso narrativo, e da un intento narrante. Ma scendiamo più nel dettaglio.
Il rapporto tra Italia e Giappone, nella stagione dei regimi totalitari (1934-45), fu complesso, ricco di ambiguità e tutt'altro che lineare: il libro, dopo un breve excursus introduttivo tra 1928 e 1934, analizza i rapporti tra i due paesi fino al Patto Tripartito e alla Guerra mondiale. Una inquieta indifferenza caratterizzò la politica estera italiana nei confronti del lontano alleato estremorientale: lo si percepisce nell'adesione tardiva dell'Italia al Patto Anticomintern, poi nella diffidenza di Roma nei confronti delle incertezze del Giappone a aderire, a sua volta, alla proposta di trasformazione dell'alleanza anticomunista in una alleanza militare di deterrenza globale. La retorica fascista rimase tuttavia incapace di formulare un proprio autonomo disegno geopolitico coerente, finendo regolarmente al rimorchio dei tedeschi, mentre i giapponesi, nel corso di una difficile stagione di elaborazione politica che sfociò definitivamente, nel 1941, in un regime militare, accettarono di unirsi alle due potenze dell'Asse solo quando riuscirono a cogliere momenti e contesti che sembrarono loro più confacenti.
Lo scopo dell'alleanza Tripartita doveva essere la creazione di zone di influenza continentali sulle quali ogni potenza avrebbe sviluppato un Nuovo Ordine autoritario, e l'area scelta dal Giappone sarebbe stata la più vasta e la più strategica. Ma i rapporti di forza, nel conflitto, decisero altrimenti.
Il libro propone quindi una storia dei patti tra Italia, Germania e Giappone, dal 1936 al tragico accordo dell'11 dicembre 1941, che segnerà le sorti della fatale alleanza delle tre potenze, che si videro di colpo tutte e tre schierate anche contro gli Stati Uniti, e indirizzate quindi verso la sconfitta nella Guerra mondiale.
La prima crisi dell'Asse fu quella italiana, e un drammatico turning point segnò la vicenda, portando Italia e Giappone a un faccia a faccia, non più come alleati, pur malfidenti, ma come ‘nemici': nel libro è proposta un'analisi della crisi del regime fascista, in relazione con l'alleato nipponico, e dei successivi rapporti tra Giappone e Repubblica Sociale Italiana.
L'8 settembre 1943, con l'uscita dell'Italia dal conflitto, e dal Tripartito, fu connotato dal conseguente sequestro delle missioni diplomatiche italiane in Giappone e Cina, episodio allora praticamente senza precedenti nella storia delle relazioni internazionali. La crisi di passaggio, determinata dall'Armistizio italiano, influenzerà pesantemente la concezione che i giapponesi avevano dell'Italia e degli italiani, riverberandosi anche nelle difficoltà della ripresa delle relazioni tra i due paesi, nel dopoguerra.
Il secondo, e meno noto, turning point è quello del 15 luglio 1945, ricordato in apertura,quando il Governo Parri, dopo la fine delle ostilità in Europa, dichiarò guerra al Giappone.
Viene proposta nel libro una serrata analisi documentale che porta all'episodio di questa dichiarazione di guerra del Governo Parri, mal conosciuto e, talora, peggio proposto, nella storiografia italiana e internazionale; ne viene studiato l'iter complessivo, connotato da dubbi, incertezze e ostacoli di questa decisione dai primi timidi approcci, nell'ottobre 1943, con Badoglio, ai tentativi dell'estate 1944, con Bonomi.
La guerra al Giappone venne decisa, alla fine, per cercare di riguadagnare una migliore considerazione internazionale proprio alla vigilia della Conferenza di Potsdam, e in vista della costituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, cui avrebbero potuto prender parte, in prima battuta, preferibilmente i Paesi in guerra contro le nazioni dell'Asse.
Il tentativo, generoso e ingenuo nello stesso tempo, non produsse però i risultati sperati: l'Italia partiva infatti con il pesantissimo handicap dell'essere una nazione sconfitta, per quanto, nel malagevole ruolo di cobelligerante (sotto regime armistiziale), avesse offerto prove sincere nella lotta al nazifascismo, con la Resistenza al Nord e, sul fronte, con un rinato embrione di esercito nazionale, schierato a combattere a fianco agli Alleati.
L'Italia aveva cominciato la guerra dalla parte sbagliata (combattendovi per tre lunghi anni), e ciò, nonostante la buona volontà americana, non poté essere dimenticato, specie da britannici e sovietici, nemmeno di fronte all'estrema offerta di provar a contribuire con le armi ad affrontare l'ultima potenza dell'Asse ancora in guerra.
Giocò a sfavore dell'estremo gesto bellico dell'Italia soprattutto l'inaspettata, rapida fine del conflitto nell'Asia orientale dopo il lancio delle bombe atomiche da parte degli americani, decisisi al terribile passo a seguito del confuso rifiuto nipponico di accogliere l'ultimatum, deciso sempre a Potsdam: a Washington, gli Stati maggiori stimarono infatti troppo onerosa, in termini di vite umane americane, l'inizialmente progettata invasione dell'arcipelago giapponese, anche tenendo conto degli esiti e delle perdite nella ultima grande battaglia nell'isola di Okinawa, combattuta sanguinosamente tra aprile e giugno 1945.
La fine della guerra mise così prematuramente fine ai tentativi italiani di organizzare un'autonoma spedizione estremorientale che probabilmente, in misura simbolica, avrebbe potuto anche esser messa a punto, ed è particolarmente ingeneroso, come si è talora fatto, ridicolizzare o banalizzare l'estrema, drammatica scelta del governo di Roma, peraltro sostenuta da uomini come Ferruccio Parri e Alcide De Gasperi, davvero al di sopra di ogni sospetto.
Il libro prende in esame, infine, le difficili relazioni tra i due Paesi che seguirono questa particolare ‘guerra non combattuta', a partire dalla timida ripresa delle relazioni (1951-52), con ampi cenni, infine, sulle trattative per le riparazioni di guerra, che si conclusero, con scarsissimo successo per l'Italia, solo dopo un ventennio, nel 1972, ma che forse nascondono ancora qualche importante coda giudiziaria (come nel caso dei risarcimenti giudiziari ancora in contenzioso per il transatlantico Conte Verde).
Massimo Gusso (Venezia, 1953) è uno studioso indipendente, politologo e storico. Si è occupato di istituzioni e politica antiche e tardoantiche, ma anche di politica italiana contemporanea e dei partiti, e ha lavorato nell'analisi di eventi della storia diplomatica di epoca risorgimentale; studia da qualche anno i rapporti italo-nipponici ed è socio dell'Associazione Italiana di Studi Giapponesi.
«Italia e Giappone: dal Patto Anticomintern alla dichiarazione di guerra del luglio 1945 - Inquiete convergenze, geopolitica, diplomazia, conflitti globali e drammi individuali (1934-1952)», di Massimo Gusso - Editrice Ca' Foscari - Venice University Press, Venezia 2022 - Prezzo € 88,00 (edizione cartacea).
Scaricabile interamente o per singolo capitolo, liberamente/gratuitamente, in formato PDF al link: http://doi.org/10.30687/978-88-6969-568-1
Fonte: Redazione
Nell'Era dei regimi totalitari il rapporto tra Italia e Giappone, pesantemente influenzato dall'ingombrante presenza tedesca, fu reciprocamente ambiguo: il nippofilo Mussolini diffidava, in realtà, dell'alleato orientale, e l'armistizio dell'8 settembre 1943 confermò tragicamente, alla fine, i costanti dubbi nipponici su un'Italia dove, successivamente (luglio 1945), il Governo democratico presieduto da Parri si sarebbe spinto a dichiarar guerra all'ex alleato, poco prima della conferenza di Potsdam. Per tentar di risollevare le sorti politico-diplomatiche dell'Italia sconfitta, Parri e i suoi, non senza affanni, presero la decisione di schierarsi contro il Giappone: l'inattesa resa giapponese vanificò la spericolata scelta, che sarebbe tuttavia ingeneroso banalizzare. Nel nuovo contesto della Guerra Fredda, ripristinare normali relazioni tra i due paesi, pur dopo una guerra non combattuta, si rivelò assai difficoltoso, dagli inizi (1951-52) e per un lungo ventennio di sfibranti trattative.
Il libro, come si comprende da titolo e sottotitolo, rappresenta un'ampia analisi sul ruolo giocato da Italia e Giappone tra la metà degli anni '30 agli inizi degli anni '50 del Novecento (e sulle loro reciproche e altalenanti simpatie, relazioni, alleanze e animosità), il tutto inserito e inquadrato in un'esposizione del contesto reticolare, politico e geopolitico, che va dalla Seconda Guerra mondiale al primo dopoguerra.
Si potrebbe sintetizzare il lavoro dicendo che si tratta di una serie di narrazioni, articolate tra loro: il racconto, ogni qualvolta è stato possibile, è stato arricchito con le parole dei protagonisti, attraverso i documenti. Per alcuni contesti, in particolare, è stata fondamentale la ricerca effettuata, a Roma, all'Archivio Storico-Diplomatico del Ministero degli Esteri.
Si tratta di vari piani “narrativi”, quello degli anni Trenta del '900, quando si forma il diabolico congegno che porterà alla più devastante guerra mai vista dall'uomo, a cui Italia e Giappone contribuirono non poco; poi la storia della caduta di Mussolini e dell'Armistizio dell'8 settembre, vista con gli occhi di chi restò travolto dagli eventi in Asia orientale, e in particolare la vicenda politica e umana dei diplomatici italiani in Giappone, finiti in prigionia per non aver accettato di mettersi al servizio della neonata Repubblica fascista; la narrazione della vicenda della dichiarazione di guerra italiana al Giappone, nel luglio del 1945, a guerra terminata in Europa – la parte del lavoro più inedita e meno studiata su una vicenda molto singolare - è incentrata soprattutto sulla ‘costruzione' di una decisione che sembra oggi fuori dal senso comune, ma che meritava di essere raccontata, dagli stentati esordi a una fine ingloriosa (o peggio per chi l'ha raccontata senza contestualizzarla). Alla fine, si trova l'importante narrazione di raccordo sulla faticosa ripresa delle relazioni italo-giapponesi. Nonostante la mole, che può forse inquietare, il libro è sorretto davvero da un impulso narrativo, e da un intento narrante. Ma scendiamo più nel dettaglio.
Il rapporto tra Italia e Giappone, nella stagione dei regimi totalitari (1934-45), fu complesso, ricco di ambiguità e tutt'altro che lineare: il libro, dopo un breve excursus introduttivo tra 1928 e 1934, analizza i rapporti tra i due paesi fino al Patto Tripartito e alla Guerra mondiale. Una inquieta indifferenza caratterizzò la politica estera italiana nei confronti del lontano alleato estremorientale: lo si percepisce nell'adesione tardiva dell'Italia al Patto Anticomintern, poi nella diffidenza di Roma nei confronti delle incertezze del Giappone a aderire, a sua volta, alla proposta di trasformazione dell'alleanza anticomunista in una alleanza militare di deterrenza globale. La retorica fascista rimase tuttavia incapace di formulare un proprio autonomo disegno geopolitico coerente, finendo regolarmente al rimorchio dei tedeschi, mentre i giapponesi, nel corso di una difficile stagione di elaborazione politica che sfociò definitivamente, nel 1941, in un regime militare, accettarono di unirsi alle due potenze dell'Asse solo quando riuscirono a cogliere momenti e contesti che sembrarono loro più confacenti.
Lo scopo dell'alleanza Tripartita doveva essere la creazione di zone di influenza continentali sulle quali ogni potenza avrebbe sviluppato un Nuovo Ordine autoritario, e l'area scelta dal Giappone sarebbe stata la più vasta e la più strategica. Ma i rapporti di forza, nel conflitto, decisero altrimenti.
Il libro propone quindi una storia dei patti tra Italia, Germania e Giappone, dal 1936 al tragico accordo dell'11 dicembre 1941, che segnerà le sorti della fatale alleanza delle tre potenze, che si videro di colpo tutte e tre schierate anche contro gli Stati Uniti, e indirizzate quindi verso la sconfitta nella Guerra mondiale.
La prima crisi dell'Asse fu quella italiana, e un drammatico turning point segnò la vicenda, portando Italia e Giappone a un faccia a faccia, non più come alleati, pur malfidenti, ma come ‘nemici': nel libro è proposta un'analisi della crisi del regime fascista, in relazione con l'alleato nipponico, e dei successivi rapporti tra Giappone e Repubblica Sociale Italiana.
L'8 settembre 1943, con l'uscita dell'Italia dal conflitto, e dal Tripartito, fu connotato dal conseguente sequestro delle missioni diplomatiche italiane in Giappone e Cina, episodio allora praticamente senza precedenti nella storia delle relazioni internazionali. La crisi di passaggio, determinata dall'Armistizio italiano, influenzerà pesantemente la concezione che i giapponesi avevano dell'Italia e degli italiani, riverberandosi anche nelle difficoltà della ripresa delle relazioni tra i due paesi, nel dopoguerra.
Il secondo, e meno noto, turning point è quello del 15 luglio 1945, ricordato in apertura,quando il Governo Parri, dopo la fine delle ostilità in Europa, dichiarò guerra al Giappone.
Viene proposta nel libro una serrata analisi documentale che porta all'episodio di questa dichiarazione di guerra del Governo Parri, mal conosciuto e, talora, peggio proposto, nella storiografia italiana e internazionale; ne viene studiato l'iter complessivo, connotato da dubbi, incertezze e ostacoli di questa decisione dai primi timidi approcci, nell'ottobre 1943, con Badoglio, ai tentativi dell'estate 1944, con Bonomi.
La guerra al Giappone venne decisa, alla fine, per cercare di riguadagnare una migliore considerazione internazionale proprio alla vigilia della Conferenza di Potsdam, e in vista della costituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, cui avrebbero potuto prender parte, in prima battuta, preferibilmente i Paesi in guerra contro le nazioni dell'Asse.
Il tentativo, generoso e ingenuo nello stesso tempo, non produsse però i risultati sperati: l'Italia partiva infatti con il pesantissimo handicap dell'essere una nazione sconfitta, per quanto, nel malagevole ruolo di cobelligerante (sotto regime armistiziale), avesse offerto prove sincere nella lotta al nazifascismo, con la Resistenza al Nord e, sul fronte, con un rinato embrione di esercito nazionale, schierato a combattere a fianco agli Alleati.
L'Italia aveva cominciato la guerra dalla parte sbagliata (combattendovi per tre lunghi anni), e ciò, nonostante la buona volontà americana, non poté essere dimenticato, specie da britannici e sovietici, nemmeno di fronte all'estrema offerta di provar a contribuire con le armi ad affrontare l'ultima potenza dell'Asse ancora in guerra.
Giocò a sfavore dell'estremo gesto bellico dell'Italia soprattutto l'inaspettata, rapida fine del conflitto nell'Asia orientale dopo il lancio delle bombe atomiche da parte degli americani, decisisi al terribile passo a seguito del confuso rifiuto nipponico di accogliere l'ultimatum, deciso sempre a Potsdam: a Washington, gli Stati maggiori stimarono infatti troppo onerosa, in termini di vite umane americane, l'inizialmente progettata invasione dell'arcipelago giapponese, anche tenendo conto degli esiti e delle perdite nella ultima grande battaglia nell'isola di Okinawa, combattuta sanguinosamente tra aprile e giugno 1945.
La fine della guerra mise così prematuramente fine ai tentativi italiani di organizzare un'autonoma spedizione estremorientale che probabilmente, in misura simbolica, avrebbe potuto anche esser messa a punto, ed è particolarmente ingeneroso, come si è talora fatto, ridicolizzare o banalizzare l'estrema, drammatica scelta del governo di Roma, peraltro sostenuta da uomini come Ferruccio Parri e Alcide De Gasperi, davvero al di sopra di ogni sospetto.
Il libro prende in esame, infine, le difficili relazioni tra i due Paesi che seguirono questa particolare ‘guerra non combattuta', a partire dalla timida ripresa delle relazioni (1951-52), con ampi cenni, infine, sulle trattative per le riparazioni di guerra, che si conclusero, con scarsissimo successo per l'Italia, solo dopo un ventennio, nel 1972, ma che forse nascondono ancora qualche importante coda giudiziaria (come nel caso dei risarcimenti giudiziari ancora in contenzioso per il transatlantico Conte Verde).
Massimo Gusso (Venezia, 1953) è uno studioso indipendente, politologo e storico. Si è occupato di istituzioni e politica antiche e tardoantiche, ma anche di politica italiana contemporanea e dei partiti, e ha lavorato nell'analisi di eventi della storia diplomatica di epoca risorgimentale; studia da qualche anno i rapporti italo-nipponici ed è socio dell'Associazione Italiana di Studi Giapponesi.
«Italia e Giappone: dal Patto Anticomintern alla dichiarazione di guerra del luglio 1945 - Inquiete convergenze, geopolitica, diplomazia, conflitti globali e drammi individuali (1934-1952)», di Massimo Gusso - Editrice Ca' Foscari - Venice University Press, Venezia 2022 - Prezzo € 88,00 (edizione cartacea).
Scaricabile interamente o per singolo capitolo, liberamente/gratuitamente, in formato PDF al link: http://doi.org/10.30687/978-88-6969-568-1
Fonte: Redazione