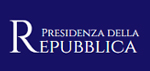Francia: ambasciata, svelato restauro facciata di Palazzo Farnese
09-12-2024 18:53 - Ambasciate
 Foto: @Stefania Casellato/Roma Capitale
Foto: @Stefania Casellato/Roma Capitale
 Foto: @Stefania Casellato/Roma Capitale
Foto: @Stefania Casellato/Roma Capitale
 Palazzo Farnese restaurato - Foto: @Stefania Casellato/Roma Capitale
Palazzo Farnese restaurato - Foto: @Stefania Casellato/Roma Capitale
GD - Roma, 9 dic. 24 - Tutto nuovo il look per la facciata principale di Palazzo Farnese, sede dell'ambasciata di Francia in Italia, il cui restauro è stato svelato oggi e che ha messo in luce le preziose intuizioni di un rinascimento in nome del Sangallo, Michelangelo, il Vignola e Della Porta, il tutto per festeggiare, nel 2025, i 150 anni di presenza francese a Palazzo Farnese.
Nel pomeriggio il pubblico presente in Piazza Farnese ha potuto così riscoprire la facciata principale di Palazzo Farnese sgombra di ponteggi, dopo quelle su Via dei Farnesi e del Mascherone. In un’unica cerimonia, Martin Briens, ambasciatore di Francia in Italia, e Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, si sono dati appuntamento in piazza Farnese: di fronte alle fontane restaurate in vista del Giubileo, inaugurate dal Sindaco e dagli assessori, è tornato a splendere il “Dado farnese” (come viene chiamato il palazzo) con i suoi colori caldi e il cornicione leonesco di Michelangelo.
L’Ambasciata di Francia in Italia, l’École française de Rome e la Soprintendenza speciale per l’archeologia, le belle arti e i paesaggi di Roma, hanno avviato nel 2021 una nuova campagna di restauro delle facciate e dei tetti di Palazzo Farnese, sede dell’ambasciata di Francia in Italia e dell’École française de Rome. Il progetto permette di ripristinare la bellezza originale dei materiali usati da quattro illustri architetti: il Sangallo, Michelangelo, il Vignola e Della Porta.
Fonte: Ambasciata
Nel pomeriggio il pubblico presente in Piazza Farnese ha potuto così riscoprire la facciata principale di Palazzo Farnese sgombra di ponteggi, dopo quelle su Via dei Farnesi e del Mascherone. In un’unica cerimonia, Martin Briens, ambasciatore di Francia in Italia, e Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, si sono dati appuntamento in piazza Farnese: di fronte alle fontane restaurate in vista del Giubileo, inaugurate dal Sindaco e dagli assessori, è tornato a splendere il “Dado farnese” (come viene chiamato il palazzo) con i suoi colori caldi e il cornicione leonesco di Michelangelo.
L’Ambasciata di Francia in Italia, l’École française de Rome e la Soprintendenza speciale per l’archeologia, le belle arti e i paesaggi di Roma, hanno avviato nel 2021 una nuova campagna di restauro delle facciate e dei tetti di Palazzo Farnese, sede dell’ambasciata di Francia in Italia e dell’École française de Rome. Il progetto permette di ripristinare la bellezza originale dei materiali usati da quattro illustri architetti: il Sangallo, Michelangelo, il Vignola e Della Porta.
L'imponente opera di maquillage era cominciata a febbraio scorso con la fase 3 dei lavori di restauro, che si è concentrata come previsto sulla manutenzione della facciata principale che dà su Piazza Farnese, sulla revisione degli infissi, nonché sul restauro delle coperture.
L'amb. Martin Briens ha sottolineato che questa 3° fase si chiude proprio intorno a “i 150 anni dell’insediamento dell’Ambasciata e dell’École française de Rome a Palazzo Farnese, mentre i lavori verranno completati per tra il 2025 e il 2026”, sottolineando quanto siano “significativi l’investimento e l’impegno della Francia nel preservare il Patrimonio culturale”. L’ultima fase, cosiddetta fase 4, si concentrerà sul restauro del muro di cinta del giardino, nonché sui versanti delle coperture di via Giulia.
Il costo dei lavori ammonta complessivamente a 5,6 milioni di euro, cofinanziati dai ministeri francesi dell’Europa e degli Affari esteri, e dell’Insegnamento superiore e della Ricerca.
La facciata e il tetto su Piazza Farnese, elementi tecnici (non esaustivo) - L'osservazione ravvicinata della facciata dall'impalcatura ha rivelato alcuni dettagli notevoli della sua composizione: un cornicione disegnato da Michelangelo con teste di leone, già “doccioni” per lo scarico dell'acqua piovana, di due epoche, XVI secolo, tra cui quella in asse con la loggia disegnata da Michelangelo, con una finezza scultorea che supera le altre; 1934, nuove teste in sostituzione di quelle danneggiate, durante l'ultimo grande restauro, in uno stile più cesellato.
Gioco di policromie sui rivestimenti in mattoni in due tonalità di ocra e rosso; quest'ultimo colore è utilizzato sia per composizioni geometriche non ripetitive, sia per sottolineare le cornici delle finestre di travertino (come un'ombra).
Travertino più fine rispetto a quello delle facciate laterali, probabilmente ordinato per favorire la facciata principale, più importante delle altre.
Lo stemma Farnese di marmo di Carrara, assunto nel XVI secolo, sormontato dai simboli del papato, la mitra papale e le chiavi di San Pietro di ghisa, materiali della seconda metà del XIX secolo.
Portone d'ingresso, di ispirazione antica, le indagini stratigrafiche hanno rivelato un colore “verde” del bronzo che è stato restaurato con una patina.
Il restauro delle coperture è stato realizzato rispettando i volumi esistenti e adattandosi alla capacità strutturale delle strutture per installare un isolamento in sughero ventilato sotto le tegole romane tradizionali esistenti.
Sotto la copertura di terra cotta, sopra il salone di Ercole, è stata effettuata la revisione di una stupenda capriata metallica, struttura di grande dimensione di tipo torre Eiffel, realizzata nel primo quarto del XX secolo.
Un cantiere nel rispetto delle teorie del restauro - Dal XVII secolo si sono susseguite varie campagne di restauro a Palazzo Farnese. Quella che ha avuto per inizio nel 2021 si colloca nella continuità e vuole proseguire gli interventi precedenti, in particolare quello realizzato in occasione del Giubileo dell’anno 2000.
Le scelte sono state eseguite nel rispetto dei principi italiani per il restauro dei monumenti storici, secondo i quali il materiale viene considerato come un’informazione di prim’ordine e da preservare.
I lavori riguardano la pulizia dell’intonaco, il consolidamento delle pietre e la revisione della copertura in tegole antiche.
Un importante lavoro viene anche svolto sugli infissi sostituiti per ripristinare, così come è già stato fatto sulle due facciate che danno su Piazza Farnese e su via Giulia, i disegni originali degli infissi del XVI secolo. Il restauro del travertino e del paramento in mattoni si svolge contemporaneamente alla ripresa delle coperture in tegole “alla romana”. Per quanto riguarda il colore delle facciate, viene ripristinato tramite una patina di armonizzazione che permetterà di attenuare l’eccessivo contrasto tra la facciata restaurata di Piazza Farnese e le facciate laterali. Un campionamento e vari prelievi sono effettuati per appurare scientificamente la composizione dei mortai e degli intonaci originali, ciò nell’intento di avvicinarsi al meglio all’opera originale.
Il restauro delle facciate e del tetto di Palazzo Farnese è stato suddiviso in quattro fasi successive il cui svolgimento è previsto su quattro anni. La prima fase è cominciata a marzo 2021 ed è stata dedicata al restauro della facciata di via dei Farnesi, degli infissi nonché delle coperture sui versanti di quella facciata; la seconda fase è stata dedicata al restauro delle facciate, degli infissi, nonché delle coperture sui versanti di via del Mascherone; la terza fase, che ha avuto inizio a fine febbraio 2024, sarà dedicata alla manutenzione della facciata principale che dà su Piazza Farnese, alla revisione degli infissi, nonché al restauro delle coperture; infine, la quarta fase si concentrerà sul restauro dei tetti di via Giulia e del muro di cinta del giardino, nonché delle coperture sui versanti di via Giulia.
Il costo dei lavori ammonta complessivamente a 5,6 milioni di euro, cofinanziati dai ministeri francesi dell’Europa e degli Affari esteri, e dell’Insegnamento superiore e della Ricerca.
Il cantiere è stato pensato in modo da minimizzare quanto possibile l’impatto sul vicinato.
L'amb. Martin Briens ha sottolineato che questa 3° fase si chiude proprio intorno a “i 150 anni dell’insediamento dell’Ambasciata e dell’École française de Rome a Palazzo Farnese, mentre i lavori verranno completati per tra il 2025 e il 2026”, sottolineando quanto siano “significativi l’investimento e l’impegno della Francia nel preservare il Patrimonio culturale”. L’ultima fase, cosiddetta fase 4, si concentrerà sul restauro del muro di cinta del giardino, nonché sui versanti delle coperture di via Giulia.
Il costo dei lavori ammonta complessivamente a 5,6 milioni di euro, cofinanziati dai ministeri francesi dell’Europa e degli Affari esteri, e dell’Insegnamento superiore e della Ricerca.
La facciata e il tetto su Piazza Farnese, elementi tecnici (non esaustivo) - L'osservazione ravvicinata della facciata dall'impalcatura ha rivelato alcuni dettagli notevoli della sua composizione: un cornicione disegnato da Michelangelo con teste di leone, già “doccioni” per lo scarico dell'acqua piovana, di due epoche, XVI secolo, tra cui quella in asse con la loggia disegnata da Michelangelo, con una finezza scultorea che supera le altre; 1934, nuove teste in sostituzione di quelle danneggiate, durante l'ultimo grande restauro, in uno stile più cesellato.
Gioco di policromie sui rivestimenti in mattoni in due tonalità di ocra e rosso; quest'ultimo colore è utilizzato sia per composizioni geometriche non ripetitive, sia per sottolineare le cornici delle finestre di travertino (come un'ombra).
Travertino più fine rispetto a quello delle facciate laterali, probabilmente ordinato per favorire la facciata principale, più importante delle altre.
Lo stemma Farnese di marmo di Carrara, assunto nel XVI secolo, sormontato dai simboli del papato, la mitra papale e le chiavi di San Pietro di ghisa, materiali della seconda metà del XIX secolo.
Portone d'ingresso, di ispirazione antica, le indagini stratigrafiche hanno rivelato un colore “verde” del bronzo che è stato restaurato con una patina.
Il restauro delle coperture è stato realizzato rispettando i volumi esistenti e adattandosi alla capacità strutturale delle strutture per installare un isolamento in sughero ventilato sotto le tegole romane tradizionali esistenti.
Sotto la copertura di terra cotta, sopra il salone di Ercole, è stata effettuata la revisione di una stupenda capriata metallica, struttura di grande dimensione di tipo torre Eiffel, realizzata nel primo quarto del XX secolo.
Un cantiere nel rispetto delle teorie del restauro - Dal XVII secolo si sono susseguite varie campagne di restauro a Palazzo Farnese. Quella che ha avuto per inizio nel 2021 si colloca nella continuità e vuole proseguire gli interventi precedenti, in particolare quello realizzato in occasione del Giubileo dell’anno 2000.
Le scelte sono state eseguite nel rispetto dei principi italiani per il restauro dei monumenti storici, secondo i quali il materiale viene considerato come un’informazione di prim’ordine e da preservare.
I lavori riguardano la pulizia dell’intonaco, il consolidamento delle pietre e la revisione della copertura in tegole antiche.
Un importante lavoro viene anche svolto sugli infissi sostituiti per ripristinare, così come è già stato fatto sulle due facciate che danno su Piazza Farnese e su via Giulia, i disegni originali degli infissi del XVI secolo. Il restauro del travertino e del paramento in mattoni si svolge contemporaneamente alla ripresa delle coperture in tegole “alla romana”. Per quanto riguarda il colore delle facciate, viene ripristinato tramite una patina di armonizzazione che permetterà di attenuare l’eccessivo contrasto tra la facciata restaurata di Piazza Farnese e le facciate laterali. Un campionamento e vari prelievi sono effettuati per appurare scientificamente la composizione dei mortai e degli intonaci originali, ciò nell’intento di avvicinarsi al meglio all’opera originale.
Il restauro delle facciate e del tetto di Palazzo Farnese è stato suddiviso in quattro fasi successive il cui svolgimento è previsto su quattro anni. La prima fase è cominciata a marzo 2021 ed è stata dedicata al restauro della facciata di via dei Farnesi, degli infissi nonché delle coperture sui versanti di quella facciata; la seconda fase è stata dedicata al restauro delle facciate, degli infissi, nonché delle coperture sui versanti di via del Mascherone; la terza fase, che ha avuto inizio a fine febbraio 2024, sarà dedicata alla manutenzione della facciata principale che dà su Piazza Farnese, alla revisione degli infissi, nonché al restauro delle coperture; infine, la quarta fase si concentrerà sul restauro dei tetti di via Giulia e del muro di cinta del giardino, nonché delle coperture sui versanti di via Giulia.
Il costo dei lavori ammonta complessivamente a 5,6 milioni di euro, cofinanziati dai ministeri francesi dell’Europa e degli Affari esteri, e dell’Insegnamento superiore e della Ricerca.
Il cantiere è stato pensato in modo da minimizzare quanto possibile l’impatto sul vicinato.
Un progetto congiunto (2017-2021) - Il progetto del restauro delle facciate e dei tetti di Palazzo Farnese è nato nel 2017. La committenza dei lavori, l’Ambasciata di Francia e l’École française de Rome, hanno promosso il progetto attraverso il dialogo costante con le amministrazioni locali. La committenza dei lavori è il service des travaux et bâtiments français en Italie (STBI). Essa è assicurata dall’agenzia di Pierre-Antoine Gatier, Capo Architetto dei Monumenti Storici e Ispettore generale dei Monumenti Storici.
Per garantire la conformità delle strategie di restauro, un comitato scientifico, composto da esperti francesi e italiani, si è riunito in varie occasioni – nel 2018, due volte nel 2019 e infine nel 2020. Il restauro è monitorato scientificamente dalla Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma.
Dal restauro alla valorizzazione - Questi lavori di restauro sono l’occasione per l’Ambasciata di Francia in Italia e l’École française de Rome di mettere in luce il patrimonio storico e artistico di Palazzo Farnese. Per questo, vari artisti e ricercatori sono invitati a portare il loro contributo per la conoscenza e l’appropriazione di questo patrimonio unico. Online o in situ, ci fanno scoprire il palazzo sotto una luce nuova, partecipano alla diffusione dei saperi attorno a questo monumento eccezionale, presentano le scoperte fatte durante i lavori e svelano il ‘’dietro le quinte’’ di un cantiere di restauro, solitamente chiusi al pubblico. Durante tutta la campagna di restauro, diversi artisti saranno invitati ad operare direttamente sulle palizzate del cantiere per proporre al pubblico una rilettura contemporanea di Palazzo Farnese e delle opere che hanno preso parte alla sua storia.
La storia dell’edificio - Le facciate di pietra e di mattone di Palazzo Farnese hanno visto la firma di quattro architetti che si sono contraddistinti a Roma: Antonio da Sangallo, Michelangelo, Vignola e Giacomo Della Porta. Nel 1513, Antonio da Sangallo avvia il cantiere della facciata principale, mentre il palazzo era già occupato dal proprietario, il cardinale Alessandro Farnese. Nel 1546, dopo la morte del primo architetto, Michelangelo porta avanti il cantiere; realizza il cornicione del Palazzo, modifica la grande finestra della facciata principale e realizza il secondo piano del cortile interno. A partire dal 1550, il Vignola partecipa all’edificazione della facciata di via del Mascherone. Infine, nel 1573, Giacomo Della Porta intraprende la costruzione dell’ala retrostante e porta a termine, nel 1589, la facciata rivolta sul Tevere.
L’edificazione delle facciate di Palazzo Farnese si protrae durante tutto il XVI secolo. A questi nomi famosi occorre aggiungere quelli degli inquilini del Palazzo, rappresentati sulla facciata da simboli ben precisi: i festoni, le palme e la quercia di Papa Alessandro VII Chigi; le spighe di grano della dinastia dei Vasa alla quale apparteneva Cristina di Svezia, che ha soggiornato a Palazzo; oppure il giglio dei Farnese.
Diventate testimonianze palesi del Rinascimento romano, queste facciate ritrovano il loro splendore iniziale attraverso la valorizzazione degli elementi inerenti alla costruzione (buche pontaie, intonaci originali).
Per garantire la conformità delle strategie di restauro, un comitato scientifico, composto da esperti francesi e italiani, si è riunito in varie occasioni – nel 2018, due volte nel 2019 e infine nel 2020. Il restauro è monitorato scientificamente dalla Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma.
Dal restauro alla valorizzazione - Questi lavori di restauro sono l’occasione per l’Ambasciata di Francia in Italia e l’École française de Rome di mettere in luce il patrimonio storico e artistico di Palazzo Farnese. Per questo, vari artisti e ricercatori sono invitati a portare il loro contributo per la conoscenza e l’appropriazione di questo patrimonio unico. Online o in situ, ci fanno scoprire il palazzo sotto una luce nuova, partecipano alla diffusione dei saperi attorno a questo monumento eccezionale, presentano le scoperte fatte durante i lavori e svelano il ‘’dietro le quinte’’ di un cantiere di restauro, solitamente chiusi al pubblico. Durante tutta la campagna di restauro, diversi artisti saranno invitati ad operare direttamente sulle palizzate del cantiere per proporre al pubblico una rilettura contemporanea di Palazzo Farnese e delle opere che hanno preso parte alla sua storia.
La storia dell’edificio - Le facciate di pietra e di mattone di Palazzo Farnese hanno visto la firma di quattro architetti che si sono contraddistinti a Roma: Antonio da Sangallo, Michelangelo, Vignola e Giacomo Della Porta. Nel 1513, Antonio da Sangallo avvia il cantiere della facciata principale, mentre il palazzo era già occupato dal proprietario, il cardinale Alessandro Farnese. Nel 1546, dopo la morte del primo architetto, Michelangelo porta avanti il cantiere; realizza il cornicione del Palazzo, modifica la grande finestra della facciata principale e realizza il secondo piano del cortile interno. A partire dal 1550, il Vignola partecipa all’edificazione della facciata di via del Mascherone. Infine, nel 1573, Giacomo Della Porta intraprende la costruzione dell’ala retrostante e porta a termine, nel 1589, la facciata rivolta sul Tevere.
L’edificazione delle facciate di Palazzo Farnese si protrae durante tutto il XVI secolo. A questi nomi famosi occorre aggiungere quelli degli inquilini del Palazzo, rappresentati sulla facciata da simboli ben precisi: i festoni, le palme e la quercia di Papa Alessandro VII Chigi; le spighe di grano della dinastia dei Vasa alla quale apparteneva Cristina di Svezia, che ha soggiornato a Palazzo; oppure il giglio dei Farnese.
Diventate testimonianze palesi del Rinascimento romano, queste facciate ritrovano il loro splendore iniziale attraverso la valorizzazione degli elementi inerenti alla costruzione (buche pontaie, intonaci originali).
Fonte: Ambasciata