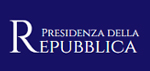Dazi amari: aspetti economico-finanziari guerra ibrida, da tariffe a moneta elettronica
08-04-2025 15:53 - Opinioni

GD - Firenze, 8 apr. 25 - La competizione tra Stati, o gruppi di Stati, si fonda anche sull’impiego di forze non materiali che possano attaccare il rivale con azioni di deterrenza indiretta, generalmente afferibili al dominio della guerra ibrida (GI). Si tratta di una forma di deterrenza che può essere esercitata tanto in chiave offensiva che di resilienza difensiva, spesso condotta con atti di guerra normativa e natura economico-finanziaria. Si consideri che allo strumento delle sovvenzioni finanziarie si fa ricorso in Cina per mantenere livelli di sovrapproduzione in grado di penetrare in dumping mercati esteri, mentre negli USA i fondi del programma IRA sono utilizzati per impedire la penetrazione cinese nel mercato dei minerali e delle batterie per auto elettriche.
Fonte: Centro Studi Politici e Strategici Machiavelli
A tali azioni di economic warfare si affiancano tradizionalmente quelle di psywar – e del soft power in particolare – non solo per generare pressione politica e psicologica, ma anche per segnalare all’estero sia l’assertività delle intenzioni della propria deterrenza, che l’intento di nascondere la propria paura, eseguendo azioni che dimostrino appunto il contrario. L’insieme di tali interventi si articola nella cornice di quelle politiche economiche che rappresentano elementi costitutivi del variegato ambito geopolitico e geoeconomico riconducibile all’economic statecraft. Tuttavia, nella formulazione degli interventi di guerra ibrida, sono necessariamente coinvolte anche le modalità con cui gli Stati definiscono i propri interessi nazionali, tenendo quindi conto anche del proprio assetto valoriale. Ciò implica la necessità di rendere contemporaneamente compatibili le implicazioni endogene degli interventi a impatto economico di guerra ibrida con i vincoli e le esigenze imposti dalla diplomazia politica e dalla politica economica nazionale.
Stando ad una recente indagine economica condotta dal Fondo Monetario Internazionale, buone politiche macroeconomiche dell’arte di governare, ed oculati investimenti a lungo termine sono in grado di allontanare i conflitti armati convenzionali. Affinché ciò avvenga è però necessario che i benefici a lungo termine delle politiche di prevenzione superino i costi associati a previsioni incerte, e che le politiche stesse siano direttamente mirate alla prevenzione dei conflitti. Purtroppo ciò non può valere per le tipologie di conflitto tipiche della guerra ibrida, in considerazione della molto più elevata incidenza – in tal caso – proprio dell’incertezza previsionale. Anche se la connotazione caratteristica dell’incertezza non è tuttavia presente allo stesso modo nelle svariate applicazioni della GI.
Interventi di guerra ibrida e flussi commerciali internazionali - Dazi, sanzioni, divieti ed embarghi commerciali, in quanto armi normative, oltre a poter essere oggetto di analisi predittiva assumendo la prospettiva del rivale, consentono all’occorrenza il vantaggio sia di poterne attenuare l’impatto economico negativo con forme elusive, sia di poter essere replicati con minacce credibili, quali contro-dazi, sviamento commerciale, ecc. Mentre numerose altre azioni della GI, non visibili se non nella loro fase applicativa, presentano livelli di insidiosità intrinseca difficilmente affrontabili ex ante, nella misura in cui – appunto – risulta quasi impossibile prevederne la realizzazione, così come individuarne i mandanti. Si pensi a quelle di natura prettamente illegale, come sabotaggio, spionaggio economico, insider trading, contrabbando e lobbismo corruttivo. Ma anche a quelle di scarsa contrastabilità ex ante: dumping, prezzi predatori, boicottaggio, utilizzo opportunistico dei flussi migratori sul piano geoeconomico, ecc.
Ciò premesso, va comunque considerato che, per massimizzare il ritorno geopolitico e geoeconomico di tali interventi, e minimizzarne le ripercussioni sull’economia nazionale, ne va attentamente calibrato il tuning. Nel caso dei divieti commerciali, l’obiettivo iniziale è selezionare prodotti e servizi con precisione strategica – si pensi ai chip avanzati – al fine di impedire, o quantomeno ritardarne, l’utilizzo da parte di rivali bersaglio nella competizione tecnologica. A questo proposito anche le buone relazioni geopolitiche con paesi alleati, che accettino anch’essi di imporre identici ban similari allo stesso Paese bersaglio, può consentire di estenderne significativamente l’impatto voluto.
La valutazione cronachistica delle attuali forme di applicazione dei dazi da parte degli Stati Uniti, significativamente eterodossa rispetto alle consolidate prescrizioni fornite dalla teoria economica in materia, ne segnala inoltre un ricorso sia in forma offensiva verso il paese rivale, sia in forma difensivo/protezionistica del proprio apparato economico. Tenendo presente che, in generale, la calibrazione applicativa dei dazi dovrebbe far sì che l’impatto complessivo degli obiettivi geoeconomici attesi (rientro di produzioni localizzate al di fuori degli USA, maggiore competitività relativa dei prodotti Made in USA rispetto a quelli d’importazione, ecc.) più che compensi i ben noti impatti negativi, riconducibili all’incentivo dell’inflazione in generale, al disincentivo alla competitività relativa delle produzioni nazionali, e soprattutto alla reazione dei paesi rivali colpiti da tali strumenti protezionistici. Sulla base di quanto sopra si dovrebbe allora parlare più di guerra commerciale che di guerra ibrida, se non fosse che l’approccio trumpiano ai dazi sembra prestarsi anche a scopi precipuamente geostrategici, oltre che protezionistico/mercantilisti, dato che, nella sua strategia, la sola minaccia dei dazi risulterebbe l’applicazione di tattiche negoziali, ad esempio con paesi confinanti, per raggiungere coercitivamente anche obiettivi geoeconomici di politica estera, sanitaria o immigratoria.
Si tratta, quindi, di obiettivi che, nel complesso, rientrano a pieno titolo nel più generale quadro delle azioni per la tutela della sicurezza nazionale. E infatti l’iniziale applicazione dei dazi all’import di acciaio ed alluminio dalla UE nel 2018 è stata giustificata, sul piano legislativo, con il ricorso all’art 232 del Trade Expansion Act del 1962, che consente di salvaguardare la produzione nazionale di tali prodotti ritenuti critici ai fini, appunto, della sicurezza nazionale. Identica motivazione aveva recentemente indotto il presidente Biden a vietare la cessione di una acciaieria USA ad un’azienda giapponese, nonostante il Giappone sia un importante alleato degli USA.
In tema di dazi va, però, aggiunto che la strategia del fine tuning viene di norma seguita anche ai fini dell’ottimizzazione della reazione da parte dei paesi inizialmente colpiti. Un criterio tipicamente applicato in tal caso è quello rispondere colpendo non solo una vasta gamma di prodotti iconici della nazione che abbia imposto i dai per prima, (nel caso degli USA: tessuti, beni agricoli e articoli come il bourbon e motociclette), ma anche e soprattutto quelli ad elevata valenza politica, in quanto provenienti da Stati americani roccaforti, o di recente conquista repubblicana. Azioni a cui, in una ottica di guerra ibrida, si potrebbe aggiungere quella del ricorso istituzionale al WTO, come già ha fatto la Cina contro i dazi USA, allo scopo di ampliare i gradi di libertà operativa nella gestione di tali interventi reattivi. Pechino ha però fatto seguire anche svariate azioni di passività offensiva, come quella della semplice interruzione dell’acquisto di prodotti commodity internazionali – quali il LNG gas USA che – una volta aumentato dei dazi – avrebbe avuto un prezzo finale ben superiore a quello importabile da altri paesi produttori.
In un contesto così intricato, sul piano istituzionale e di mercato, molto complesso sarebbe per gli USA stimare correttamente un vantaggio in termini di costi/benefici economici, quando si dovesse passare – come appunto sembra – dai dazi su singole commodities alle tariffe invece «reciproche» sulle importazioni da specifici paesi. Poiché in tal caso sarebbe necessario valutare anche l’impatto di barriere non tariffarie, quali tassazione (IVA), tassi di cambio e sussidi.
Per quanto concerne un possibile ricorso a tali strumenti anche da parte della la UE, va detto che l’applicazione di contingenti massimi di import di specifici prodotti da taluni paesi, a valere sulla clausola cosiddetta di Salvaguardia, potrebbe prestarsi a fungere da arma ibrida, se venissero formulata anche sulla base di motivazioni di natura geopolitica.
Interventi di guerra ibrida e relazioni economico-finanziarie internazionali - Di rilievo, in proposito, sono gli impatti creati da ulteriori svariate normative a valenza sia coercitiva che anticoercitiva; e fra queste è frequente il ricorso alle sanzioni economiche come strumento di guerra ibrida. In considerazione del fatto che, se obiettivo del paese A è il non raggiungimento dell’obiettivo X da parte del paese B, le sanzioni consentono ad A di applicarle al paese B – e per effetto dell’extraterritorialità anche a soggetti terzi non del paese B – con l’intento di far desistere dal perseguire, o indurre a non perseguire l’obiettivo X.
Tra le applicazioni storiche di tali azioni, attuate con il fine di dissuadere, o interrompere dal proseguire, basti citare le ben note sanzioni dell’OFAC statunitense verso l’Iran, miranti ad interrompere le attività di tale paese bersaglio nello sviluppo del nucleare e, nel caso della Corea del nord, a interrompere anche la fabbricazione di missili balistici o di altre armi strategiche. Mentre, nel caso delle sanzioni USA e UE contro la Russia, in presenza di un evento bellico già attuato, come la conquista della Crimea, o in corso come quello attuale contro l’Ucraina, il ruolo della sanzione economico-finanziaria diviene duplice. Rimane formalmente ascritto a quello di uno strumento di guerra ibrida, concepito per indebolire la base economica della Russia, privandola di tecnologie e mercati fondamentali, in quanto nazione che, nel 2014, aveva compromesso o minacciato l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza di un’altra nazione. Mentre attualmente funge da arma economico/finanziaria a impatto aggiuntivo, (ma non certo risolutivo) a quello delle armi convenzionali dispiegate nel conflitto armato.
È però noto anche l’impatto collaterale negativo di tali sanzioni, poiché generano danni economici indiretti sull’economia degli stessi paesi che le impongono, non solo per le inevitabili limitazioni alle loro esportazioni ed investimenti, ma anche per il costo economico-finanziario delle contro-sanzioni applicate dal paese bersaglio. Inoltre, in considerazione delle multiforme tipologie di elusione di tali sanzioni, il loro tuning applicativo dovrebbe basarsi su dati di intelligence economica difficilmente reperibili – o anche solo immaginabili – ex ante. Per il fatto che tali operazioni elusive vengono in gran parte ideate ex post, appunto sulla base della configurazione applicativa delle sanzioni imposte.
Anche le attività di sabotaggio, in quanto armi di guerra ibrida, sono attualmente oggetto di sempre più frequente informazione cronachistica. La dashboard infografica su incidenti sospetti ed atti di sabotaggio in Europa presentata nella Relazione 2025 del DIS al Parlamento evidenza platealmente come i bersagli siano quasi tutti i paesi europei coinvolti nel sostegno militare all’Ucraina nel conflitto in corso. In quanto assimilabili per finalità agli attacchi cyber ad infrastrutture strategiche di un paese bersaglio, si ricorre ai sabotaggi per la loro peculiare capacità di diffondere ira e risentimento nella popolazione colpita da tali gesti, quando non un sentimento di collera, con possibili e pericolosi esiti deleteri sul piano sociale e sulla coesione delle compagini governative del paese bersaglio.
Sarebbe naturalmente lungo analizzare le numerose altre armi utilizzabili per scopi di guerra ibrida:
Stando ad una recente indagine economica condotta dal Fondo Monetario Internazionale, buone politiche macroeconomiche dell’arte di governare, ed oculati investimenti a lungo termine sono in grado di allontanare i conflitti armati convenzionali. Affinché ciò avvenga è però necessario che i benefici a lungo termine delle politiche di prevenzione superino i costi associati a previsioni incerte, e che le politiche stesse siano direttamente mirate alla prevenzione dei conflitti. Purtroppo ciò non può valere per le tipologie di conflitto tipiche della guerra ibrida, in considerazione della molto più elevata incidenza – in tal caso – proprio dell’incertezza previsionale. Anche se la connotazione caratteristica dell’incertezza non è tuttavia presente allo stesso modo nelle svariate applicazioni della GI.
Interventi di guerra ibrida e flussi commerciali internazionali - Dazi, sanzioni, divieti ed embarghi commerciali, in quanto armi normative, oltre a poter essere oggetto di analisi predittiva assumendo la prospettiva del rivale, consentono all’occorrenza il vantaggio sia di poterne attenuare l’impatto economico negativo con forme elusive, sia di poter essere replicati con minacce credibili, quali contro-dazi, sviamento commerciale, ecc. Mentre numerose altre azioni della GI, non visibili se non nella loro fase applicativa, presentano livelli di insidiosità intrinseca difficilmente affrontabili ex ante, nella misura in cui – appunto – risulta quasi impossibile prevederne la realizzazione, così come individuarne i mandanti. Si pensi a quelle di natura prettamente illegale, come sabotaggio, spionaggio economico, insider trading, contrabbando e lobbismo corruttivo. Ma anche a quelle di scarsa contrastabilità ex ante: dumping, prezzi predatori, boicottaggio, utilizzo opportunistico dei flussi migratori sul piano geoeconomico, ecc.
Ciò premesso, va comunque considerato che, per massimizzare il ritorno geopolitico e geoeconomico di tali interventi, e minimizzarne le ripercussioni sull’economia nazionale, ne va attentamente calibrato il tuning. Nel caso dei divieti commerciali, l’obiettivo iniziale è selezionare prodotti e servizi con precisione strategica – si pensi ai chip avanzati – al fine di impedire, o quantomeno ritardarne, l’utilizzo da parte di rivali bersaglio nella competizione tecnologica. A questo proposito anche le buone relazioni geopolitiche con paesi alleati, che accettino anch’essi di imporre identici ban similari allo stesso Paese bersaglio, può consentire di estenderne significativamente l’impatto voluto.
La valutazione cronachistica delle attuali forme di applicazione dei dazi da parte degli Stati Uniti, significativamente eterodossa rispetto alle consolidate prescrizioni fornite dalla teoria economica in materia, ne segnala inoltre un ricorso sia in forma offensiva verso il paese rivale, sia in forma difensivo/protezionistica del proprio apparato economico. Tenendo presente che, in generale, la calibrazione applicativa dei dazi dovrebbe far sì che l’impatto complessivo degli obiettivi geoeconomici attesi (rientro di produzioni localizzate al di fuori degli USA, maggiore competitività relativa dei prodotti Made in USA rispetto a quelli d’importazione, ecc.) più che compensi i ben noti impatti negativi, riconducibili all’incentivo dell’inflazione in generale, al disincentivo alla competitività relativa delle produzioni nazionali, e soprattutto alla reazione dei paesi rivali colpiti da tali strumenti protezionistici. Sulla base di quanto sopra si dovrebbe allora parlare più di guerra commerciale che di guerra ibrida, se non fosse che l’approccio trumpiano ai dazi sembra prestarsi anche a scopi precipuamente geostrategici, oltre che protezionistico/mercantilisti, dato che, nella sua strategia, la sola minaccia dei dazi risulterebbe l’applicazione di tattiche negoziali, ad esempio con paesi confinanti, per raggiungere coercitivamente anche obiettivi geoeconomici di politica estera, sanitaria o immigratoria.
Si tratta, quindi, di obiettivi che, nel complesso, rientrano a pieno titolo nel più generale quadro delle azioni per la tutela della sicurezza nazionale. E infatti l’iniziale applicazione dei dazi all’import di acciaio ed alluminio dalla UE nel 2018 è stata giustificata, sul piano legislativo, con il ricorso all’art 232 del Trade Expansion Act del 1962, che consente di salvaguardare la produzione nazionale di tali prodotti ritenuti critici ai fini, appunto, della sicurezza nazionale. Identica motivazione aveva recentemente indotto il presidente Biden a vietare la cessione di una acciaieria USA ad un’azienda giapponese, nonostante il Giappone sia un importante alleato degli USA.
In tema di dazi va, però, aggiunto che la strategia del fine tuning viene di norma seguita anche ai fini dell’ottimizzazione della reazione da parte dei paesi inizialmente colpiti. Un criterio tipicamente applicato in tal caso è quello rispondere colpendo non solo una vasta gamma di prodotti iconici della nazione che abbia imposto i dai per prima, (nel caso degli USA: tessuti, beni agricoli e articoli come il bourbon e motociclette), ma anche e soprattutto quelli ad elevata valenza politica, in quanto provenienti da Stati americani roccaforti, o di recente conquista repubblicana. Azioni a cui, in una ottica di guerra ibrida, si potrebbe aggiungere quella del ricorso istituzionale al WTO, come già ha fatto la Cina contro i dazi USA, allo scopo di ampliare i gradi di libertà operativa nella gestione di tali interventi reattivi. Pechino ha però fatto seguire anche svariate azioni di passività offensiva, come quella della semplice interruzione dell’acquisto di prodotti commodity internazionali – quali il LNG gas USA che – una volta aumentato dei dazi – avrebbe avuto un prezzo finale ben superiore a quello importabile da altri paesi produttori.
In un contesto così intricato, sul piano istituzionale e di mercato, molto complesso sarebbe per gli USA stimare correttamente un vantaggio in termini di costi/benefici economici, quando si dovesse passare – come appunto sembra – dai dazi su singole commodities alle tariffe invece «reciproche» sulle importazioni da specifici paesi. Poiché in tal caso sarebbe necessario valutare anche l’impatto di barriere non tariffarie, quali tassazione (IVA), tassi di cambio e sussidi.
Per quanto concerne un possibile ricorso a tali strumenti anche da parte della la UE, va detto che l’applicazione di contingenti massimi di import di specifici prodotti da taluni paesi, a valere sulla clausola cosiddetta di Salvaguardia, potrebbe prestarsi a fungere da arma ibrida, se venissero formulata anche sulla base di motivazioni di natura geopolitica.
Interventi di guerra ibrida e relazioni economico-finanziarie internazionali - Di rilievo, in proposito, sono gli impatti creati da ulteriori svariate normative a valenza sia coercitiva che anticoercitiva; e fra queste è frequente il ricorso alle sanzioni economiche come strumento di guerra ibrida. In considerazione del fatto che, se obiettivo del paese A è il non raggiungimento dell’obiettivo X da parte del paese B, le sanzioni consentono ad A di applicarle al paese B – e per effetto dell’extraterritorialità anche a soggetti terzi non del paese B – con l’intento di far desistere dal perseguire, o indurre a non perseguire l’obiettivo X.
Tra le applicazioni storiche di tali azioni, attuate con il fine di dissuadere, o interrompere dal proseguire, basti citare le ben note sanzioni dell’OFAC statunitense verso l’Iran, miranti ad interrompere le attività di tale paese bersaglio nello sviluppo del nucleare e, nel caso della Corea del nord, a interrompere anche la fabbricazione di missili balistici o di altre armi strategiche. Mentre, nel caso delle sanzioni USA e UE contro la Russia, in presenza di un evento bellico già attuato, come la conquista della Crimea, o in corso come quello attuale contro l’Ucraina, il ruolo della sanzione economico-finanziaria diviene duplice. Rimane formalmente ascritto a quello di uno strumento di guerra ibrida, concepito per indebolire la base economica della Russia, privandola di tecnologie e mercati fondamentali, in quanto nazione che, nel 2014, aveva compromesso o minacciato l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza di un’altra nazione. Mentre attualmente funge da arma economico/finanziaria a impatto aggiuntivo, (ma non certo risolutivo) a quello delle armi convenzionali dispiegate nel conflitto armato.
È però noto anche l’impatto collaterale negativo di tali sanzioni, poiché generano danni economici indiretti sull’economia degli stessi paesi che le impongono, non solo per le inevitabili limitazioni alle loro esportazioni ed investimenti, ma anche per il costo economico-finanziario delle contro-sanzioni applicate dal paese bersaglio. Inoltre, in considerazione delle multiforme tipologie di elusione di tali sanzioni, il loro tuning applicativo dovrebbe basarsi su dati di intelligence economica difficilmente reperibili – o anche solo immaginabili – ex ante. Per il fatto che tali operazioni elusive vengono in gran parte ideate ex post, appunto sulla base della configurazione applicativa delle sanzioni imposte.
Anche le attività di sabotaggio, in quanto armi di guerra ibrida, sono attualmente oggetto di sempre più frequente informazione cronachistica. La dashboard infografica su incidenti sospetti ed atti di sabotaggio in Europa presentata nella Relazione 2025 del DIS al Parlamento evidenza platealmente come i bersagli siano quasi tutti i paesi europei coinvolti nel sostegno militare all’Ucraina nel conflitto in corso. In quanto assimilabili per finalità agli attacchi cyber ad infrastrutture strategiche di un paese bersaglio, si ricorre ai sabotaggi per la loro peculiare capacità di diffondere ira e risentimento nella popolazione colpita da tali gesti, quando non un sentimento di collera, con possibili e pericolosi esiti deleteri sul piano sociale e sulla coesione delle compagini governative del paese bersaglio.
Sarebbe naturalmente lungo analizzare le numerose altre armi utilizzabili per scopi di guerra ibrida:
- disinformazione e propaganda organizzate online (anche per colpire sul piano reputazionale imprese quotate e icone nazionali):
- spionaggio, ora realizzabile con l’aiuto dell’AI anche attraverso infrastrutture fisiche quali pale eoliche, automobili, sensoristica diffusa, ecc.
- spionaggio, ora realizzabile con l’aiuto dell’AI anche attraverso infrastrutture fisiche quali pale eoliche, automobili, sensoristica diffusa, ecc.
- guerra diplomatica, subdole modalità di aggiramento dei vincoli imposti dalla normativa del Golden Power, per disporre di servizi o prodotti tecnologici fondamentali per il mantenimento di un vantaggio strategico nei confronti di paesi rivali target;
- violazione della proprietà intellettuale e industriale;
- canalizzazione territoriale con finalità geopolitica del percorso dei migranti;
- sfruttamento economico e/o deviazione del percorso internazionale dell’acqua dei fiumi con finalità geopolitiche;
- percorso internazionale dell’acqua dei fiumi con finalità geopolitiche–svalutazioni;
- geocriminalità. Guerra Ibrida, financial warfare e criptovalute.
Forse in nessun altro momento storico, come nell’attuale competizione di potenza, il fattore finanziario ha assunto una così formidabile connotazione come arma di guerra ibrida. Ciò in quanto l’operatività degli intermediari finanziari appare sempre di più proiettata anche verso strumenti finanziari, quali le criptovalute, che possono essere ingegnerizzate e utilizzate anche con finalità di guerra ibrida, ma soprattutto perché abilità l’insorgenza di contesti regolatori potenzialmente idonei favorire il ricorso a strumenti di guerra ibrida. In merito a tale ultimo punto basta pensare che la competitività delle imprese nazionali dipende anche dalla disponibilità dell’apparato finanziario a sostenerle nelle loro necessità di investimento.
Disponibilità che non può prescindere dalle condizionalità di natura operativa cui le banche sono sottoposte dal rispetto dei requisiti del capitale di vigilanza. Ma tali requisiti, definiti da appositi accordi internazionali (vedi le regole di Basilea 3 che impongono nuovi obblighi prudenziali) sono al momento entrati in vigore nel solo ambito giuridico della UE, dato che la propensione alla deregulation negli USA non sta assolutamente generando pressione istituzionale in tal senso. Con il risultato di generare un disallineamento di regole attualmente idoneo a consentire un potenziale ricorso strumentale all’arbitraggio regolamentare al di là dell’Atlantico. A questo si aggiunge un ulteriore rischio riconducibile all’approvando Regolamento UE FIDA, quello di poter acquisire ed utilizzare, da parte di terzi quali i grandi fondi gestori patrimoniali – ma anche i cosiddetti Big Tech – importanti dati ed informazioni finanziarie ricavabili dal mondo bancario, dietro autorizzazione della clientela. Situazione che, stante l’intreccio talora in apparente tra l’operatività di tali soggetti ed il perseguimento di interessi nazionali, consentirebbe loro di servirsi strumentalmente anche della valenza geopolitica delle info in tal modo acquisibili.
Per quanto concerne invece il delicato tema dell’operatività prospettica delle criptovalute, va sottolineato un quadro di minacce incombenti, più che di rischi. L’insorgenza di tale minaccia può già da tempo identificarsi nella tematica geopolitica della dedollarizzazione, mirata ad indebolire il ruolo del dollaro come valuta di riserva, centrale nei pagamenti internazionali, e ad aprire in tal senso uno spazio operativo a valute digitali come quella cui punta attualmente il gruppo dei paesi BRICS.
Disponibilità che non può prescindere dalle condizionalità di natura operativa cui le banche sono sottoposte dal rispetto dei requisiti del capitale di vigilanza. Ma tali requisiti, definiti da appositi accordi internazionali (vedi le regole di Basilea 3 che impongono nuovi obblighi prudenziali) sono al momento entrati in vigore nel solo ambito giuridico della UE, dato che la propensione alla deregulation negli USA non sta assolutamente generando pressione istituzionale in tal senso. Con il risultato di generare un disallineamento di regole attualmente idoneo a consentire un potenziale ricorso strumentale all’arbitraggio regolamentare al di là dell’Atlantico. A questo si aggiunge un ulteriore rischio riconducibile all’approvando Regolamento UE FIDA, quello di poter acquisire ed utilizzare, da parte di terzi quali i grandi fondi gestori patrimoniali – ma anche i cosiddetti Big Tech – importanti dati ed informazioni finanziarie ricavabili dal mondo bancario, dietro autorizzazione della clientela. Situazione che, stante l’intreccio talora in apparente tra l’operatività di tali soggetti ed il perseguimento di interessi nazionali, consentirebbe loro di servirsi strumentalmente anche della valenza geopolitica delle info in tal modo acquisibili.
Per quanto concerne invece il delicato tema dell’operatività prospettica delle criptovalute, va sottolineato un quadro di minacce incombenti, più che di rischi. L’insorgenza di tale minaccia può già da tempo identificarsi nella tematica geopolitica della dedollarizzazione, mirata ad indebolire il ruolo del dollaro come valuta di riserva, centrale nei pagamenti internazionali, e ad aprire in tal senso uno spazio operativo a valute digitali come quella cui punta attualmente il gruppo dei paesi BRICS.
Le valute digitali assumono veste strumentale anche di arma ibrida in quanto – a differenza delle valute fiat – possono essere ingegnerizzate per una serie di utilizzi strategicamente ampia: consentono di evitare sanzioni, possono essere riservate a beneficio solo di certe categorie di persone o aziende, possono servire solo per scopi normativi determinati algoritmicamente. Stando infine ad un recente Executive Order di Trump, gli USA potranno servirsi delle cripto a disposizione del governo statunitense, in quanto oggetto di sequestro o confisca, per costituire una «riserva strategica» utilizzabile in situazioni di crisi – al pari delle riserve di petrolio, medicinali ecc – ma in un’ottica di riduzione del debito pubblico (una riserva strategica da non confondere con la borsa della resilienza in preparazione da parte della UE!).
Per quanto concerne infine le valute digitali create ed emesse dalle banche centrali estere (la BCE per i paesi dell’Eurozona), negli USA non saranno ammesse. In relazione invece ad un prossimo utilizzo delle stablecoin a fianco del dollaro, è in corso un’analisi delle modalità di emanazione/applicazione di tali valute presso il parlamento americano che sembra segnalare sin d’ora l’obiettivo di un loro supporto al dollaro fiat. In considerazione dello stato embrionale della normativa USA in materia, non se ne potrebbe neppure escludere un utilizzo alternativo alle monete tradizionali, tenuto conto del possibile coinvolgimento della FED come prestatore di ultima istanza. Sul piano geopolitico rileva comunque il fatto che, nella misura in cui le stablecoin di pagamento sono sostenute da asset a riserva denominati in dollari – non sono ammesse al momento le stablecoin algoritmiche – potranno essere accettate ed utilizzate anche all’estero come strumento di pagamento. E quanto maggiore la domanda di tali stablecoin, maggiore la domanda di dollari USA o di asset denominati in questa divisa.
Vanno poi considerate le ampliate possibilità di arma ibrida delle stablecoin quali mezzi di pagamento per atti di sabotaggio, corruzione, propaganda, nonché per terrorismo ed operazioni di riciclaggio. La UE si sta attrezzando al riguardo con il regolamento MICA, mentre la BCE è prossima ad emettere l’euro digitale. E, però, mentre l’euro digitale avrebbe limiti di detenzione per non ridurre i depositi bancari, le stablecoin non ne prevedono alcuno. Al riguardo è stato autorevolmente sottolineato come la diffusione di stablecoin ancorate a valute diverse dall’euro, potrebbe arrivare ad intaccare la sovranità monetaria dell’Eurozona. Sembra delinearsi pertanto un quadro prospettico di relazioni geoeconomiche caratterizzato da una acuta competizione tra giurisdizioni finanziarie, e da fonti di arbitraggio normativo che, nel settore delle criptovalute, potrebbe rivelarsi altamente insidioso sul piano del risparmio e della stabilità dei sistemi finanziari europei.
Per quanto concerne infine le valute digitali create ed emesse dalle banche centrali estere (la BCE per i paesi dell’Eurozona), negli USA non saranno ammesse. In relazione invece ad un prossimo utilizzo delle stablecoin a fianco del dollaro, è in corso un’analisi delle modalità di emanazione/applicazione di tali valute presso il parlamento americano che sembra segnalare sin d’ora l’obiettivo di un loro supporto al dollaro fiat. In considerazione dello stato embrionale della normativa USA in materia, non se ne potrebbe neppure escludere un utilizzo alternativo alle monete tradizionali, tenuto conto del possibile coinvolgimento della FED come prestatore di ultima istanza. Sul piano geopolitico rileva comunque il fatto che, nella misura in cui le stablecoin di pagamento sono sostenute da asset a riserva denominati in dollari – non sono ammesse al momento le stablecoin algoritmiche – potranno essere accettate ed utilizzate anche all’estero come strumento di pagamento. E quanto maggiore la domanda di tali stablecoin, maggiore la domanda di dollari USA o di asset denominati in questa divisa.
Vanno poi considerate le ampliate possibilità di arma ibrida delle stablecoin quali mezzi di pagamento per atti di sabotaggio, corruzione, propaganda, nonché per terrorismo ed operazioni di riciclaggio. La UE si sta attrezzando al riguardo con il regolamento MICA, mentre la BCE è prossima ad emettere l’euro digitale. E, però, mentre l’euro digitale avrebbe limiti di detenzione per non ridurre i depositi bancari, le stablecoin non ne prevedono alcuno. Al riguardo è stato autorevolmente sottolineato come la diffusione di stablecoin ancorate a valute diverse dall’euro, potrebbe arrivare ad intaccare la sovranità monetaria dell’Eurozona. Sembra delinearsi pertanto un quadro prospettico di relazioni geoeconomiche caratterizzato da una acuta competizione tra giurisdizioni finanziarie, e da fonti di arbitraggio normativo che, nel settore delle criptovalute, potrebbe rivelarsi altamente insidioso sul piano del risparmio e della stabilità dei sistemi finanziari europei.
Massimo Ortolani,
analista geoeconomico, già nel gruppo ENI (Agip Spa) e poi al Mediocredito Centrale. È stato consulente per conto della UE in Kazakhstan e, per l’UNIDO, in Colombia e Perù; docente di Master sulla Sicurezza Nazionale alle università di Tor Vergata e Link. È autore di Intelligence economica e conflitto geoeconomico.
Fonte: Centro Studi Politici e Strategici Machiavelli